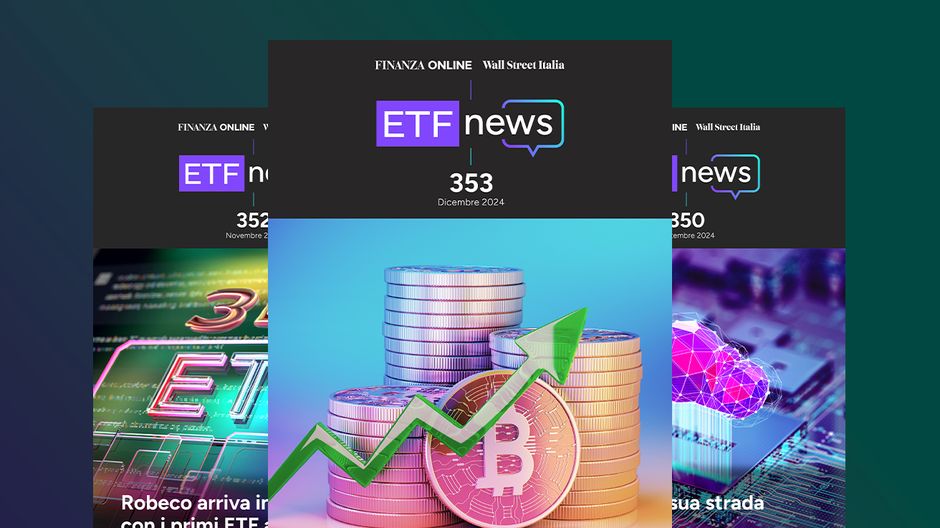Risparmiatori: 52 miliardi andati in fumo per salvare le mele marce della finanza

Oltre un miliardo di euro. E’ il totale dei risparmi degli italiani andati in fumo soltanto nei primi sei mesi del 2012. E non per tasse, rincari o riduzione della busta paga causa cassa integrazione, ma per la malafinanza.
Del resto la cosiddetta socializzazione delle perdite, contraltare della privatizzazione degli utili ora di gran moda nell’Europa della crisi che taglia il welfare a piene mani per tappare i buchi, è sempre stata di casa dove scorrono i soldi dei risparmiatori.
Per dare un’idea delle cifre in gioco, secondo le stime dell’Adusbef i crac finanziari dal 2001 ai giorni nostri sono costati complessivamente 52 miliardi di euro che sono stati scuciti dalle tasche di 1,121 milioni di comuni cittadini, per una spesa media unitaria di 46.387 euro.
E il calcolo è parziale, perché tiene conto solo dei casi finiti in Tribunale, ma infinite sono le vie, anche quelle legali, per privatizzare gli utili e socializzare le perdite. Tanto più in Borsa, dove i risparmiatori meno avvezzi ai giochi di prestigio sono soprannominati il parco buoi, ma dove chi decide di giocare si assume il rischio d’impresa. Senza contare i costi dell’intervento pubblico, delle perdite di posti di lavoro e delle conseguenza per il territorio. Anche per l’anno che ci buttiamo alle spalle, quindi, ce n’è per tutti i generi e tipi.
I GRANDI CLASSICI DEL CRAC. Con un costo stimato, sempre dall’Adusbef, in 860 milioni di euro il primo e 160 milioni il secondo, sono stati i casi Deiulemar e Banca Network a fare la parte del leone nella prima metà dell’anno coinvolgendo oltre 42mila risparmiatori.
Per il crac della compagnia di navigazione di Torre del Greco delle famiglie Della Gatta, Iuliano e Lembo è stato disposto il giudizio immediato con la prima udienza in calendario per il prossimo 11 marzo. Ma sarà lunga sdipanare la matassa di una vicenda che ha dell’incredibile, dove i milioni raccolti presso i risparmiatori, ma anche vip locali e capiclan, non venivano messi a bilancio e depositati direttamente sui conti correnti personali del capostipite degli armatori, senza alcun controllo alla faccia delle normative sull’antiriciclaggio.
“Chi è causa del suo mal pianga se stesso”, ha commentato qualcuno. Che dire invece della vicenda di Banca Network Investimenti, Bni, il cui slogan era “Una banca efficiente. Sempre al tuo fianco”, salvo poi lasciare a piedi 69 dipendenti e 28mila correntisti che quest’estate si sono visti congelare i conti da un giorno con l’altro in attesa dell’intervento del Fondo di tutela dei depositi?
Per non parlare della sorte degli obbligazionisti che avevano finanziato con oltre 32 milioni di euro la Sopaf dei fratelli Magnoni che aveva in mano la maggioranza della banca e che a sua volta è crollata in autunno sotto il peso di oltre 100 milioni di debiti. Ma che grazie alla riforma del diritto fallimentare, in tema di concordati preventivi introdotta dal governo Monti con il decreto Sviluppo, viaggia ancora tra le tutele del concordato e il fallimento.
A secco, quindi, creditori e, ancor di più, i piccoli azionisti che soltanto nell’ultimo anno di scambi, in Borsa hanno assistito al tracollo del titolo che ha bruciato l’84% del suo valore. Proprio mentre il socio di maggioranza, Giorgio Magnoni fratello del più noto Ruggero, ex presidente di Lehman Brothers per l’Italia, “faceva affari d’oro nell’immobiliare sull’asse tra il Lussemburgo e la Germania”, come riportato dal quotidiano Mf lo scorso 12 dicembre.
Immancabili, quindi, gli accertamenti in corso da parte della magistratura sulla vicenda Sopaf, come su quella di Banca Network che include gli investimenti in titoli rischiosi da parte dell’istituto A partire da quelli targati Lehman Brothers.
PRODOTTI BANCARI FINITI IN CLASS ACTION. Ma i soldi dei risparmiatori non finiscono solo nelle azioni delle società quotate in Borsa. Ci sono sia i prodotti finanziari più o meno strutturati, sia i banali conti correnti. Un’area piuttosto vasta e delicata, quindi, che quest’anno ha registrato il via della prima class action nei confronti di un gruppo bancario, Intesa SanPaolo.
Oggetto del contendere, che potrebbe riguardare fino a 400mila clienti dell’istituto, alcune spese di conto che sono state introdotte dalla banca in sostituzione delle commissioni di massimo scoperto abolite per legge nel 2009 e giudicate illegittime da Altroconsumo, che ha promosso l’azione collettiva partita a settembre. Il termine per l’adesione è il prossimo 21 gennaio, mentre l’appuntamento in Tribunale a Torino per il conteggio finale delle adesioni è fissato per marzo.
In attesa degli esiti della più ampia inchiesta della magistratura sulla gestione della Banca Popolare di Milano di Massimo Ponzellini, si sta invece chiudendo con una conciliazione da almeno 40 milioni di euro la triste vicenda del convertendo allegro della Bpm, il bond ad alto rischio da 170 milioni di euro che era stato venduto nel 2009 senza la necessaria informazione a 15mila clienti della banca milanese oggi nelle mani di Andrea Bonomi.
L’intesa, però, non porterà a grandi risultati per i consumatori secondo l’Aduc, unica associazione che non l’ha firmata commentando che “questi tavoli di conciliazione si risolvono in una buffonata a danno dei risparmiatori ed a vantaggio in primo luogo della Banca (che paga una piccola frazione di quello che dovrebbe sborsare), secondariamente delle associazioni che vi partecipano”.
MANCATI INCASSI. Notevole, poi, la lista delle fregature assolutamente legali. Come le uscite dal listino a prezzi convenientissimi per l’azionista di maggioranza, ma piuttosto deludenti per il piccolo investitore costretto giocoforza ad aderire alle Offerte pubbliche di acquisto (Opa) perché in minoranza. E’ il caso, per esempio, di Benetton, con la famiglia di Ponzano Veneto che a febbraio ha approfittato dei prezzi da saldo per ritirare dal mercato la società dei maglioncini a un controvalore di circa 270 milioni di euro pari a 4,6 euro per azione. Somma che secondo il Sole 24 Ore equivale pro quota a meno del solo valore degli immobili della società.
“Sempre meglio che niente”, commenta chi invece è rimasto a bocca asciutta. In caso di cambio di controllo di una società quotata, per offrire a tutti i soggetti coinvolti la stessa possibilità di guadagno, la normativa prevede infatti l’obbligo del lancio di un’Opa allo stesso prezzo per tutti gli azionisti. Legge che però si può aggirare.
In prima istanza fermandosi alla soglia 29,99% del capitale, basta che non ci sia un accordo segreto con altri azionisti per avere comunque la maggioranza nelle assemblee dove si prendono le decisioni importanti senza pagare il dazio ai soci di minoranza. E’ proprio su questa ipotesi che sta indagando la Procura di Milano a proposito della vittoria del gruppo Salini sul rivale Gavio all’assemblea di Impregilo dello scorso luglio, che peraltro è stata dichiarata regolare dal Tribunale, anche se sulla sentenza pende un ricorso in appello. La questione non è da poco, anche perché tra la ragnatela di interessi che gravitano intorno alla società di costruzioni c’è l’appalto per il Ponte sullo Stretto di Messina con annesse penali da mezzo miliardo a carico dello Stato.
Ancor più delicato, coi tempi che corrono, il tema delle esenzioni dall’Opa nei casi accertati di salvataggio delle società in crisi. Come quello del gruppo Premafin-Fondiaria Sai che fu dei Ligresti che ha tenuto banco per tutto l’anno. E anche qui la Procura indaga, tra il resto, sull’ipotesi dell’esistenza di accordi irregolari nell’ambito dell’esenzione dal lancio dell’Opa concessa dalla Consob a Unipol, a patto che dal piano orchestrato da Mediobanca venissero cancellati i vantaggi previsti per la famiglia Ligresti, dato che avrebbero premiato l’azionista uscente e per di più responsabile del dissesto, lasciando a bocca asciutta gli altri investitori.
Le clausole sono state cancellate, ma a fine luglio gli stessi Ligresti hanno fatto saltar fuori un ipotetico accordo segreto da 45 milioni con l’amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, che nella faccenda, in quanto creditore miliardario sia verso i Ligresti che verso Unipol, aveva tutti gli interessi a che l’operazione andasse a buon fine.
GRUPPI E CREDITI DA SALVARE. Ma quella del papello Nagel-Ligresti è sola una delle tappe della vicenda Ligresti al vaglio degli inquirenti tra Milano e Torino. Come è ancora tutta da giocare la partita entrata nel vivo nel 2012 sul salvataggio dei grandi gruppi quotati con una buona dose di debiti che non fanno dormire sonni tranquilli né ai banchieri, né ai grandi azionisti.
E talvolta neppure allo Stato. Si va dall’immane debito dell’editrice del Corriere della Sera, Rcs, che coinvolge tutto quel che resta del gotha della finanza italiana che sul tema continua a prendere tempo, al buco del Monte dei Paschi di Siena, passando per Parmalat e Telecom Italia, a proposito della quale perfino un manager pubblico come Franco Bassanini si è appena unito al coro della richiesta di un incentivo statale, per aiutare la società soffocata da 30 miliardi di debiti frutto di una privatizzazione “sbagliata” ad aprire la rete agli altri operatori.
Quel che è certo, intanto, è che nel caso Unipol-FonSai i risparmiatori, inclusi quelli che avevano investito sulla compagnia delle Coop, oltre che con l’Opa mancata possono già fare i conti con l’evaporazione di investimenti per una somma complessiva compresa tra 300 e 400 milioni di euro. In quello del Monte dei Paschi, i soldi, 3,9 miliardi più altri 550 milioni potenziali per gli interessi, arrivano direttamente dal contribuente via ministero del Tesoro.
Mentre su Parmalat pagano innanzitutto i dipendenti, che con la prevista chiusura di tre stabilimenti rischiano il posto di lavoro. Intanto l’azionista francese Lactalis si è premurato di vendere a Collecchio una sua società americana, portandosi a casa metà del tesoretto da 1,5 miliardi raccolto da Enrico Bondi con le azioni legali contro le banche per il crac di Calisto Tanzi, che era custodito nelle casse del gruppo.
E che così ha finito col servire anche ad alleggerire i debiti dei francesi verso Mediobanca, che a Lactalis nel 2011 aveva prestato 410 milioni proprio per l’acquisto di Parmalat. Anche qui la magistrature è al lavoro, l’ipotesi a carico dei vertici della società è di appropriazione indebita. Ma è difficile che si arrivi a un punto prima di una decisione definitiva sulle sorti del centinaio di dipendenti italiani a rischio.
Copyright © Il Fatto Quotidiano. All rights reserved